«L’indomani ero partita per il Vietnam. C’era la guerra
in Vietnam e se uno faceva il giornalista finiva prima o poi per andarci.
Perché ce lo mandavano, o perché lo chiedeva. Io l’avevo chiesto. Per dare a me
stessa la risposta che non sapevo dare a Elisabetta, la vita cos’è, per
ricercare i giorni in cui avevo troppo presto imparato che i morti non
rinascono a primavera».
È il 1968. A scrivere, da una camera dell’ultimo hotel ancora in piedi a Saigon, in Vietnam, è Oriana Fallaci. I suoi articoli di inviata, pubblicati sull’Europeo, arrivano in un’Italia scossa dalla contestazione e sono una pioggia di parole che, invece di placare i dibattiti, ne accende di nuovi. Cos’è che le rende capaci di scardinare le nostre rassicuranti certezze? Cos’è che ce le fa sembrare fastidiose, dolorose, difficili?
È il 1968. A scrivere, da una camera dell’ultimo hotel ancora in piedi a Saigon, in Vietnam, è Oriana Fallaci. I suoi articoli di inviata, pubblicati sull’Europeo, arrivano in un’Italia scossa dalla contestazione e sono una pioggia di parole che, invece di placare i dibattiti, ne accende di nuovi. Cos’è che le rende capaci di scardinare le nostre rassicuranti certezze? Cos’è che ce le fa sembrare fastidiose, dolorose, difficili?
In un’intervista
del 1991 a TG1 Sette, mentre dalla Guerra del Golfo lamenta gli ostacoli che
gli Stati coinvolti pongono ai giornalisti, Oriana spiega: «Forse ci sarebbe da
vedere lo sbarco, ma non ci prenderanno. Probabilmente, se riusciremo a entrare
nel Kuwait, ci entreremo quando avranno fatto pulizia. Nel Vietnam abbiamo
raccontato troppo i morti, li abbiamo fatti vedere troppo, con le parole e con
le immagini. E loro non vogliono che si vedano i morti».
Per chi sceglie di fare il giornalista il confronto con queste parole è in realtà uno scontro. Uno scontro quotidiano con un uragano di parole e di pressioni. Dalle storie più semplici da comprendere e da raccontare, i residenti di un quartiere che chiedono una corsa aggiuntiva all’autobus, alle storie più delicate, come le decine di lastre di amianto abbandonate, ancora oggi, all’ex area Necchi.
Per chi sceglie di fare il giornalista il confronto con queste parole è in realtà uno scontro. Uno scontro quotidiano con un uragano di parole e di pressioni. Dalle storie più semplici da comprendere e da raccontare, i residenti di un quartiere che chiedono una corsa aggiuntiva all’autobus, alle storie più delicate, come le decine di lastre di amianto abbandonate, ancora oggi, all’ex area Necchi.
Ricordo il primo incontro con quella che sarebbe diventata poi la mia fonte
principale sul tema, ricordo il plico di fogli che mi ha allungato sul tavolo,
un vero e proprio dossier fatto di analisi, resoconti, dati e fotografie,
ricordo le serate passate a studiare le carte per verificarne la veridicità.
Ogni parola mi parlava, non solo scientificamente, non solo razionalmente, ma
anche emotivamente. I numeri sull’inquinamento della falda acquifera non erano
e non sono solo numeri, i numeri dei poliziotti che lavoravano lì a pochi metri
e che sono morti per tumore negli ultimi anni non sono numeri.
Quando iniziano le interviste arriva uno tsunami di parole: le parole di paura di chi lavora lì, le parole di dolore di chi ha perso un caro e non sa trovare pace, le parole di allarme di alcuni esperti, le parole rassicuranti di altri esperti, le parole fredde della burocrazia e i tanti, troppi silenzi. Ma quando inizi a scrivere l’articolo le difficoltà non fanno un passo indietro. Perché il giornalista inizia a essere tirato per la giacchetta, a volte in realtà spintonato senza troppi riguardi: l’editore vuole un indirizzo, il caposervizio vuole un titolo, la fonte vuole una notizia, gli intervistati che hanno parlato vogliono spazio, gli intervistati che hanno taciuto vogliono poco rumore. E allora, quali parole usare?
Quando iniziano le interviste arriva uno tsunami di parole: le parole di paura di chi lavora lì, le parole di dolore di chi ha perso un caro e non sa trovare pace, le parole di allarme di alcuni esperti, le parole rassicuranti di altri esperti, le parole fredde della burocrazia e i tanti, troppi silenzi. Ma quando inizi a scrivere l’articolo le difficoltà non fanno un passo indietro. Perché il giornalista inizia a essere tirato per la giacchetta, a volte in realtà spintonato senza troppi riguardi: l’editore vuole un indirizzo, il caposervizio vuole un titolo, la fonte vuole una notizia, gli intervistati che hanno parlato vogliono spazio, gli intervistati che hanno taciuto vogliono poco rumore. E allora, quali parole usare?
Ricordo un reportage molto corposo su ciò che
accade la sera in piazza duomo, quando le pareti della cattedrale vengono usate
come una latrina a cielo aperto dai frequentatori della piazza. Parole,
immagini, interviste a tutti coloro i quali potevano intervenire,
rappresentanti del potere civile e religioso. Eppure, nonostante le numerose
mail e telefonate giunte in redazione, tutto si è spento pian piano e, ad oggi,
la situazione notturna per il duomo di Pavia non è cambiata di molto, se non
per una nuova recinzione provvisoria a difesa delle mura.
Cos’è che ha soffocato l’indignazione? Non c’è solo l’interesse dei potenti di turno, piccoli o grandi che siano, c’è una sorta di assuefazione che ha colpito l’opinione pubblica.
Cos’è che ha soffocato l’indignazione? Non c’è solo l’interesse dei potenti di turno, piccoli o grandi che siano, c’è una sorta di assuefazione che ha colpito l’opinione pubblica.
Bombardati quotidianamente, anzi ogni volta che accediamo a internet dallo
smartphone, da notizie superficiali, che rendiamo ancora più superficiali
perché spesso ci fermiamo al titolo, senza verificarne né la firma né la
testata. Ma se crediamo di essere sempre più liberi, così non è. Perché
l’accesso potenziale a tutte queste informazioni non è realizzabile, e non è
nemmeno libero. Molte notizie ci vengono date seguendo una continua
riproposizione di schemi rassicuranti. Fateci caso sfogliando un quotidiano o
navigando su una testata online: populismo, razzismo, fascismo, immigrazione,
accoglienza, sono i tag più utilizzati. E sono tag rassicuranti, perché ci
permettono di identificarci in una posizione precostituita: io sono buono, tu
sei cattivo. Eppure la verità non è rassicurante, non è comoda, non è
superficiale. È semplicemente vera.
Nel flusso ininterrotto di parole che ci bombardano è rimasta fuori, ad esempio, la vicenda di Vincent Lambert, paziente tetraplegico 42enne. Vincent è francese, è ricoverato in un ospedale francese, e secondo alcuni giudici francesi la sua qualità della vita è troppo bassa, perciò la sua vita va eliminata. Eppure, chi ha scritto di lui? Solo Tempi ha aperto l’edizione online con la notizia della sentenza. Chi ha condiviso link per lui? Non con lunghi editoriali, non con poemi, non con considerazioni, ma con fatti. Puri e semplici fatti: Vincent è stato condannato a morire di fame e di sete perché tetraplegico. E allora come deve comportarsi un giornalista quando ha una notizia, quando sente di doverla portare alla conoscenza dell’opinione pubblica e non gli viene concesso spazio?
Sono tante le domande,
e non ci sono risposte facili. Una certezza però c’è: non si può pensare di
trovare le parole giuste, di usare le parole migliori, se non è partiti dalla
ricerca della verità. Verificare ogni informazione che si riceve o si trova,
confrontarla con gli altri dati che si hanno a disposizione, ascoltare anche la
propria coscienza. Chi crede sa che lì c’è una scintilla divina, che può
aiutarci a illuminare, almeno in parte, la verità. La verità con la V
maiuscola, certo, ma anche le tante verità quotidiane che siamo chiamati a
riconoscere e a raccontare con onestà.
Non tutti siamo chiamati a raccontare le guerre, non tutti siamo chiamati a scoprire una cura che cambierà le sorti della medicina o a progettare un ponte capace di resistere ai terremoti. Ma tutti siamo chiamati a ricercare la verità. Chi racconta le notizie, ma anche chi le riceve. Solo così, solo partendo da un’onesta ricerca della verità, potremo costruire quel mondo meraviglioso che il titolo di questa bella serata ha evocato. (testimonianza per la serata “What a wonderful word”, 6 febbraio 2019, Soul Food 4 you, Convento Santa Maria Incoronata di Canepanova, Pavia)
Grazie
al team di Soul Food 4 you per l’invito e la calorosa accoglienza. Mercoledì
sera luminosi per la città.


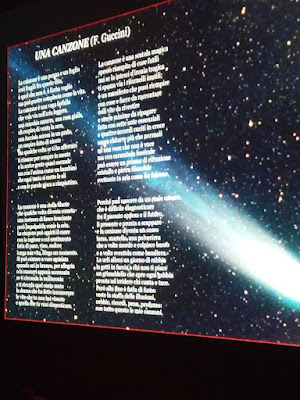


Nessun commento:
Posta un commento
E tu, cosa ne pensi?